Questo saggio è già uscito su “Studi Novecenteschi”.
Come già Quando vi ucciderete maestro? e Cronaca della fine, anche Signore delle lacrime è un libro a cavallo tra i generi. Diario di un viaggio in India con gli amici francesi Luc e Nathalie o saggio sulla divinità indiana Śiva; paradossale «romanzo-testamento» o riflessione sul senso della fine, Signore delle lacrime mostra alcune caratteristiche fondamentali del saggio personale di tradizione anglosassone: la costruzione autobiografica, innanzi tutto, ma ancor di più quella libertà di associazioni di pensiero e quel particolare procedere cogitante per cui, come ha scritto un maestro del genere, il libro diventa «l’equivalente di una mente che rumina»[1]. Se nelle prove precedenti Franchini si concentrava – pur attraverso uno sguardo sempre divagante – su argomenti specifici (la scrittura di Mishima, un «caso» editoriale), il fuoco che anima Signore delle lacrime è molto chiaramente la libera interrogazione sull’esistenza, il tentativo di un bilancio di un uomo. L’obiettivo del testo è dunque distillare il manzoniano «sugo della storia». Con una differenza: non di storia romanzesca, costruita a tavolino, e di persone di carta si tratta qui. Ma della volontà di un padre di trovare le «parole ultime [da] lasciare a un figlio», di «tramandare quel che [si è] capito della vita».
L’argomento è da far tremare le vene ai polsi, e tanto più quanto è dichiarato con immediatezza, con – se si vuole – naïveté:
” In ogni viaggio è contenuta la possibilità di non tornare molto di più di quanto la fine non sia implicita nella vita di tutti i giorni.
Le condizioni ordinarie non sollecitano la resa dei conti quanto quelle fuori dalla norma.
Allora ho immaginato che stavo per morire e dovevo lasciar detto qualcosa ai miei figli.”
Franchini è, però, tutto tranne che un narratore sprovveduto e sa che, se gli «argomenti buoni sarebbero un’infinità», le parole invece «rischiano di mancare perché suonano vacue o impostate o già dette, a meno di non provenire da una verginità assoluta».
Ancor più che romanzo-saggio à la Musil, Signore delle lacrime è un romanzo-meditazione. Montaigne, certo: non solo come riferimento obbligato ad ogni non fiction di matrice autobiografico-saggistica, ma soprattutto per l’apparente naturalezza con la quale il bagaglio di conoscenze filosofiche e critiche è calato nel concreto, strettamente legato ad un’esperienza quotidiana: è quella «semplicità contrapposta alla presunzione intellettuale» di cui ha parlato La Capria nell’Estro quotidiano a proposito degli Essais:
“L’autobiografia come forma di conoscenza, e la semplicità contrapposta alla presunzione intellettuale, questo mi piace in lui [Montaigne]. Mi piace che parta sempre dall’esperienza personale, che parli di fatti concreti, di episodi e personaggi della storia, che lui racconta e sottopone al vaglio del senso comune. E come può innalzarsi e diventare poco comune il senso comune in una mente come la sua!”[2]
Proprio la concretezza e la (solo apparente) semplicità sono gli elementi più riconoscibili nella scrittura di Franchini (e di La Capria, non a caso autore del raffinatissimo Elogio del senso comune). La verità di Signore delle lacrime, allora, non consiste tanto (o non solo) nell’effettiva occorrenza dell’occasione esteriore – il viaggio in India o i dettagli di alcune esperienze – ma nell’autenticità e urgenza della sua interrogazione, in quel «senso di una presenza umana» di cui ha parlato Klaus e che è la cifra stilistica peculiare delle migliori narrazioni autobiografico-saggistiche da Montaigne a Joan Didion[3].
Come già nei libri precedenti, Franchini costruisce un testo perfettamente calibrato tra il racconto/meditazione dell’evento presente e il flash back memoriale. Il rischio potrebbe essere una struttura fortemente discontinua nella quale i singoli frammenti di esperienza, se pur significativi per sé, non riescono tuttavia ad amalgamarsi in una storia. Il montaggio è invece perfetto, e le differenti narrazioni funzionano come tessere di un mosaico: le singole storie servono come punti di osservazione diversi sul medesimo argomento e, in costante dialogo tra loro, si arricchiscono vicendevolmente sino a formare un tutto coeso. Tale unità è garantita anche grazie ad una precisa strategia linguistica. Attraverso un’accorta economia lessicale (che non è in nessun caso povertà), infatti, Franchini utilizza ripetutamente lemmi appartenenti al medesimo campo semantico. Si formano così delle isotopie – soprattutto legate all’opposizione durata/finitezza – che appaiono periodicamente in punti-chiave del libro, anche tra loro molto distanti, richiamando l’attenzione del lettore sul filo rosso che lega le differenti vicende.
La morte – celebrata nei ghat, vista in una stazione indiana o su un Eurostar Roma-Milano, o solo immaginata – rappresenta il motore primo di una riflessione sul senso possibile del procedere dell’uomo nel mondo. Un uomo-viandante, quindi, come avverte la citazione che apre il volume:
“Il “viaggio” è sempre un simbolo della prova iniziatica. Si chiama Brahmacārin (l’“errante nell’immensità”) il novizio che cerca di acquisire il sapere e la conoscenza […] Nella prima e nell’ultima parte della vita ogni uomo deve dedicarsi essenzialmente allo studio e a mendicare il cibo. Dopo di che deve praticare l’erranza.”
Il viaggio è fortemente simbolico, e osservare i roghi funebri dei ghat significa – per l’occidentale narratore – aprirsi all’esperienza collettiva della morte, partecipare al rito del termine del viaggio, e meditare sul quel significato nascosto cui ogni rito allude.
La descrizione più dolorosamente rivissuta della precarietà dell’uomo, tuttavia, è offerta attraverso un flash back memoriale e privato. Si tratta della rimemorazione di una festa – la «festa dello gnocco fritto» – durante la quale il narratore è informato della morte di Claudio, «l’amico più caro della […] giovinezza».
Come accadeva nell’Abusivo – dove l’affermazione «hanno ammazzato un mio amico» era immediatamente preceduta dalla rappresentazione comico-grottesca delle liti tra il «Locusto» e la madre – anche qui la tragedia è presentata attraverso un contrasto di temi e registri: «È mentre adagio sullo gnocco fritto una fetta di spalla cotta che suona il cellulare. La voce è quella di un amico assai intimo, che però non sento da anni, e dice scusa se ti disturbo, è per una brutta notizia, stamattina è finito Claudio». Se nel caso dell’Abusivo il contrasto tra l’affermazione tragica e il «non necessario» della scena comica serviva come certificazione di verità del narrato, qui il discorso è diverso. La figura di Claudio – studioso di lingue classiche – è anticipata lessicalmente e tematicamente dagli accenni al «talamo pensato come quello di Ulisse» del padrone di casa, e dalla sua stessa occupazione: «scrittore di fama mondiale e esperto di antichità classiche». Il contrasto è dato quindi soprattutto dalle isotopie figurativo-tematiche della durata – gli alberi del giardino scelti perché «simboleggiano, da sempre, l’idea della durata», ad esempio, o la «fama» del padrone di casa e la ricorrenza apparentemente atemporale, ciclica, della festa ripetuta «ogni anno, al sopraggiungere dell’estate» – e la subitaneità della morte dell’amico: «Al cellulare ho detto le cose che si dicono in questi casi e che non significano niente. Non provavo niente. Ad una certa età le reazioni rallentano come il decorso delle malattie, anche se il tumore che si è portato via Claudio ha agito in fretta». Tale contrasto è poi enfatizzato poiché alla durata delle piante e del mondo non viene contrapposta la morte dell’amico, ma il più forte – e inusuale – finire: «ha detto così: “è finito”. La forma tenue di morto, la litote di solito è “mancato”; “finito” è un peggiorativo, semmai, ma lui ha detto così, è finito».
Sono, queste, pagine di rara intensità, nelle quali la rievocazione dell’amico si alterna alla narrazione di dettagli apparentemente insignificanti sui grassi saturi della cicciolata o sulle ali di pollo tandoori; piccole notazioni filologiche precedono considerazioni sulla nostra capacità di ricordare a partire da un vecchio spot televisivo:
“Quando eravamo giovani il mio amico pensava alla morte assai più spesso di quanto normalmente facciano i giovani.
Vi alludeva, come è costume tra i cultori del mondo classico, in due diversi, opposti modi, alternando ora l’uno ora l’altro: o con il muto terrore che folgora il mortale davanti all’Erebo, o con l’accettazione stoica, il distacco sprezzante per cui – e avevamo poco più di vent’anni – citava Tacito che, a proposito del comportamento dei Germani di fronte alla morte, scrive foeminis lugere, hominibus meminisse decet. […]
Perché a vent’anni, non avendo niente da ricordare, eravamo tanto attratti da questo senile culto del ricordo?
Perché a cinquanta, con altrettanta incoerenza, lo rifuggiamo? […]
Come è possibile, dice, che tu ti ricordi una pubblicità così brutta e nata sfigata che andò in onda pochissimo?
Non lo so perché me la ricordo, però me la ricordo.
Hominibus meminisse.
Tacito non dice, evidentemente, che cosa ricordare. Dava per scontato che si ricordassero persone e gesta degne. Siamo noi che facciamo bene a non dare niente per scontato. E infatti ricordiamo cazzate. Un mare di cazzate.”[4]
Ciò che viene mostrato qui è la difficoltà di costruire la propria vita a partire dal ricordo di «persone e gesta degne», di durare nella contemplazione della – uso l’espressione di Franchini stesso nell’Abusivo – «cosa che brucia dopo tanto scivolare di ombre».
La nota dominante è la pietà; pietà per la fragilità dell’uomo completamente messa a nudo: non solo la fragilità del corpo che soccombe («in fretta») alla malattia, ma anche la fragilità dell’anima. Le manifestazioni dell’anima, come il corpo vinto dalle malattie, sono condannate alla brevità (a «finire», appunto): come il giovane narratore aveva imparato al ritorno a casa dopo una visita particolarmente toccante ad un monastero, «la tensione dell’anima non dura e il ritorno a terra è un approdo amaro perché è inevitabile e strisciante, odora di detersivo».
La contrapposizione tra i due registri (quello solenne della rievocazione dell’amico e quello quotidiano della festa) serve soprattutto a svelare la possibilità che nell’apparente caoticità della vita si nasconda un ordine segreto, fatto di «coincidenze, di premonizioni, di corrispondenze» che possono essere riconosciute solo «dopo, molto dopo».
” Anche il fatto che la notizia della tua morte mi abbia raggiunto nella villa di un uomo che per un importante aspetto ti assomiglia è una circostanza cui ho pensato soltanto dopo, molto dopo, e testimonia che, solo a volercele trovare, la vita diventa un cumulo di coincidenze, di premonizioni, di corrispondenze.
Eravate due perfetti coetanei […] entrambi perfettamente estranei al mondo attorno, avete sognato eroi, studiato grammatiche morte e congetturato topografie scomparse da millenni.
Viris meminisse.”
Il passo, di diverse pagine, meriterebbe di essere citato per intero. Anche attraverso questo breve estratto, tuttavia, possiamo notare uno stilema che Franchini adotta in due punti-chiave del libro e che definisce il tono della narrazione in tutta la parte finale: l’iterazione di una frase paradigmatica – quasi un’invocazione da coro tragico – che scandisce il capitolo in «lasse» che affrontano lo stesso tema a partire da esperienze diverse. Tale struttura appare per la prima volta nell’ultimo terzo del libro: è il momento in cui il narratore, impegnato in un trekking nella valle sacra dello Yamuna, rievoca stati d’animo «che h[a] patito o h[a] visto patire». Come accade agli esperti camminatori, le gambe procedono automaticamente, «vanno per conto loro», non hanno bisogno dell’aiuto del pensiero. Così libero, il narratore cerca dunque di «concepire qualcosa da lasciar detto ai [suoi] figli, nella convinzione [della] fine imminente»; ben presto, però, si accorge della difficoltà di astrarre, di trovare un significato agli apparentemente irrelati eventi della vita: sembra che uscendo «dai miseri casi che ci sono toccati e sui quali ci sembra di avere tanto da commentare, non ci sia nulla di più generico su cui l’intelligenza sappia far presa». Ancora una volta, il sentimento che prevale è la pietà, pietà per l’uomo, per la sua impossibilità di trovare e ancor più condividere un senso. Come se questo non potesse essere mai affermato positivamente, ma solo evocato attraverso il silenzio:
” Questo episodio – dicevo mentalmente ai miei figli, camminando – significa che qualche volta vorrete dire qualcosa a qualcuno e per qualche ragione non saprete farlo. Può essere che la persona a cui volevate parlare se ne accorga, e allora il vostro silenzio dirà molto di più di qualsiasi parola, ma è molto più facile che non se ne accorga e allora quel silenzio peserà sempre e solo sopra di voi.
Signore delle lacrime.”
Signore delle lacrime, cioè Śiva, il dio ambiguo: principio di distruzione e creazione, simbolo dell’ascetismo e della più sfrenata carica erotica, il «luogo di tutti i paradossi». Ma lo Śiva evocato qui è soprattutto la divinità che piange sul destino umano, e che distruggendo permette la rinascita poiché è (anche) la morte della morte, cioè la vita eterna. L’impiego di uno stilema proprio della poesia, o della preghiera – l’iterazione, qui, delle due invocazioni «Signore delle lacrime» e delle citazioni latine viris meminisse e hominibus meminisse – trasforma la meditazione in commemorazione, in liturgia o rito laico di fronte alla morte. Come La Capria che, nell’Estro quotidiano, scriveva degli amici Giovanni e Kiki sentendo «la responsabilità della loro sopravvivenza», anche per Franchini uno dei compiti positivi della letteratura, forse il solo, è in questa testimonianza delle vite che ci hanno dato vita e che non sono più.
Non possono non venire in mente le parole del narratore (ancora una volta autobiografico) dell’Abusivo quando affermava che la scrittura è «soprattutto treno, epicedio, canto funebre»:
” Ho letto con commozione il ritratto di un amico morto scritto da un altro amico. Non so se è perché io sono rimasto sensibile soprattutto, o solo, alle cose che mi toccano da vicino, come forse è normale che sia per tutti. […] La letteratura non dovrebbe funzionare così, la letteratura dovrebbe essere finzione. O anche finzione.
Eppure secondo me le pagine più belle ― o sono le più facili? ― scritte dai miei coetanei sono ricordi di morti. […] Questa forse è solo una fissazione mia, ma alle volte mi sembra che essa sia diventata (se non lo è sempre stata) soprattutto treno, epicedio, canto funebre.”
In effetti, Signore delle lacrime mi pare il libro in cui i temi prediletti di Franchini si ricapitolano e trovano una loro sintetica compiutezza. La lingua stessa trova qui una maturità e una naturalezza eccezionali: è una lingua che – pur nella molteplicità dei registri toccati, dal lirico al quotidiano – sembra modellata sui classici (e dei classici ha la levigata solidità), o su quei canti funebri evocati nell’Abusivo e nella dedica del libro, «a Claudio Ferone, in memoriam». Anche Signore delle lacrime – come e forse ancor più dell’Abusivo – trova quindi il suo motivo più profondo nella pietà e nel ricordo: è canto e meditazione sulla vita che onora chi non è più.
Signore delle lacrime, tuttavia, non si esaurisce nella meditazione sulla morte; essa rappresenta piuttosto – così come le citazioni dalle Upaniṣad – il basso continuo, la «musica di fondo» di una narrazione fortemente divagante e nella quale anche gli eventi minimi e concreti del viaggio servono da punto di partenza per la discussione di temi più complessi e generali. La differenza tra l’ossessione fotografica di Luc e Nathalie, e la reticenza del narratore a «frapporre una lente tra [sé] e i paesaggi, tra [sé] e gli uomini», ad esempio, dà l’occasione per riflettere sul dissidio tra vivere e vedersi vivere:
Luc e Nathalie fanno fotografie. Macchine professionali gli pendono dal collo […] Io invece vado in giro senza niente o con un apparecchio di cartone usa e getta […]. Ho sempre pensato che se cominciassi a frapporre una lente tra me e i paesaggi, tra me e gli uomini, finirei con il non vederli più perché fatalmente rinvierei l’emozione al momento di ritrovarmeli, nitidi e nuovi, diversi, sulla stampa, e allora vivrei con senso di colpa un sentimento posposto che è atto mancato, non vita.[…] Questa macchina usa e getta è l’incarnazione di due sensi di colpa, quello di appoggiarsi ad un aiuto esterno e quello di fare a meno di tutto, quello di voler testimoniare la vita e quello di voler soltanto vivere.
Il tema, fra i più cari a Franchini fin dagli esordi, è strettamente legato alla riflessione sul valore testimoniale della letteratura, e quindi del libro stesso che ci accingiamo a leggere (siamo – vale la pena sottolinearlo – alla prima pagina). Così come le fotografie dei suoi compagni di viaggio, anche il resoconto che si accinge a scrivere non potrà che restituire un’altra realtà – forse meno ricca, forse più strutturata e coerente, ma certamente diversa.
Parlare dell’esperienza che si è appena vissuta significa, per Franchini, parlare di qualcosa che manca, e che può essere definito solo negativamente: il reale non è né luminoso come le foto di Luc né sfocato come la sua scrittura ma, appunto, ciò che sfugge ad entrambi:
” Le foto di Luc saranno sempre più alla giusta distanza, più definitive di questa evasiva realtà che vediamo.
Che cos’è allora la realtà del nostro viaggio? È il luogo intermedio, è l’esperienza più luminosa delle mie foto sfuocate e più sfuocata delle luminose foto di Luc?
Scrivere come fotografando è ancora un altro modo di posporre la vita, con la stessa foga e timidezza, la stessa aspirazione a durare e lo stesso destino a sparire.”
Naturalmente, da scrittore avvertito quale è, Franchini sa benissimo che l’inafferrabilità del mondo è specchio di un’inafferrabilità più radicale e problematica: quella dell’io. Soggetto che guarda e oggetto guardato sono entrambi frammentari ed elusivi. Come un paesaggio che cambia a seconda del punto dal quale lo guardiamo (e da cosa sa vedere chi lo guarda), l’identità stessa è «una questione di prospettiva» più che «un’essenza».
In effetti, la scrittura di Franchini si muove costantemente in questo double bind della necessità di testimoniare e l’impossibilità di una rappresentazione fedele, completa, «vera»; del desiderio di vivere nell’attimo e di ricordare, cioè posporre l’emozione di quell’attimo.
C’è però un momento in cui il nodo si scioglie, in cui non c’è più tempo per interrogarsi e la riflessione lascia il posto ad una primitiva gioia di esistere (di durare, se pure non per sempre). Non stupisce che questo fiotto di pura esistenza esploda in un urlo – veramente liberatorio. Il narratore sta scendendo con la canoa una rapida particolarmente impegnativa:
Si comincia a fare sul serio quando, grazie al cielo, ho già smesso di pensare […] Non stiamo a interrogarci sulla vita, viviamo e basta […] Urlo. Ecco perché si urla, urlo per farmi coraggio ma anche perché sono felice, perché nel fragore dell’acqua nessuno mi sente, perché almeno una volta sarò passato su questa terra urlando senza ritegno e senza motivo, solo perché esistevo.
È solo un momento, ma il suono di questo urlo di gioia risuona per tutto il libro. Signore delle lacrime non è un libro disperato; non lascia, alla fine, un senso di tristezza perché dietro ogni più seria riflessione sulla morte, dietro ogni più amara considerazione sull’incomunicabilità tra uomo e uomo, persiste sempre l’eco di quel grido come richiamo alla possibilità, concreta e imminente, della felicità.
Dato il doppio piano tematico sul quale sempre si muove la riflessione di Franchini, non stupirà che la notazione sull’instabilità dell’io poco fa notata sia immediatamente riportata anche al livello di teoria della letteratura. La consapevolezza di un io effimero, aperto a tutte le interpretazioni, pone lo scrittore di fronte a tre alternative: «continuare a scrivere senza porsi il problema, non scrivere più, scrivere sgretolando generi, personaggi, storia». Se all’autore stesso tali opzioni sembrano troppo schematiche, e se – ancora attraverso un double bind – la solidità della storia e dei personaggi gli appare «più appagante», cioè preferibile, non c’è dubbio che, in tutti i suoi libri, Franchini scelga senza esitare la terza alternativa. Sgretolare le storie e i generi non significa, però, distruggerli: essi rimangono, mi sembra, sotto forma di residui, di scaglie che la scrittura ripropone in un precario e fittizio ordine ottenuto grazie a quell’assemblaggio «di vecchie e difformi pietre» di cui parlava già l’Abusivo. Allo stesso modo, sgretolare i personaggi non significa rinchiuderli nell’autismo di quei «personaggi assoluti» di cui ha parlato Enrico Testa in un bel saggio recente, ma ridefinirli a partire di un’idea di identità come – uso ancora le parole di Testa – «dymamis originaria che apre il soggetto al ritmo per cui l’altro pulsa già da sempre nel Medesimo»[5]. Se dire io nel romanzo è «solo il raccattare volenteroso e lo stringere orgoglioso un fascio funesto di volizioni, sensazioni, ricordi», una identità-punto di vista rimane, e si costruisce nella relazione con il mondo e con altre identità-punto di vista.
Il problema discusso da Franchini, del resto, potrebbe essere riproposto quasi negli stessi termini anche per l’attività critica. In questo caso le alternative sarebbero pressappoco queste: continuare a scrivere critica senza porsi il problema (come se quella letteraria fosse davvero una scienza: c’è chi lo ha fatto, o ha tentato di farlo), rinunciare ad ogni giudizio critico, scrivere utilizzando più metodi, intendendo quindi la critica come sintesi di diverse prospettive motivate razionalmente.
La questione non è da poco, perché tocca da vicino la legittimità stessa del giudizio critico o, più specificatamente, del giudizio di valore. Il fatto, di per sé lapalissiano, che i giudizi del critico conservino sempre un certo grado di arbitrarietà (sono sempre dettati anche dal gusto personale), non ne esclude la necessità, così come la rappresentazione di un personaggio o di una situazione sempre dipende dal particolare punto di osservazione scelto dall’autore. Ne ha parlato, e bene, Onofri nel suo La ragione in contumacia: se il giudizio non è dimostrabile come un teorema e non può mai raggiungere quel consenso di tutti a cui pure aspirerebbe, è perché di esso non si possono dare prove. Però: si possono, anzi si devono, dare argomenti[6]. Vale a dire: anche la critica – come il romanzo – è tanto più ricca quanto meno è dogmatica e chiusa in se stessa. L’argomentare, infatti, presuppone sempre il dialogo con l’altro, la continua revisione e messa a punto dei propri strumenti di indagine.
Ma torno subito, per concludere, al libro di Franchini. Da un certo punto di vista – lo ha sottolineato La Porta nella sua recensione sul “Messaggero” – Signore delle lacrime continua una tradizione, novecentesca e italiana, di tentativi di comprensione di un paese che ancor oggi, «nell’epoca della scomparsa dell’altrove e dell’esotico», può apparire come «un’alterità irriducibile»: da Verso la cuna del mondo di Gozzano, passando per Un’idea dell’India di Moravia fino a L’odore dell’India di Pasolini, «l’incontro fisico con il subcontinente indiano» ha preso «la forma di un qualche malessere, fatto di smarrimento e di meraviglia, di scoperta e di rigetto». Signore delle lacrime non fa eccezione, e forse ancor più dei volumi che lo hanno preceduto, mostra come l’India rappresenti soprattutto il momento di un’«insondabile esperienza interiore»[7].
Rispetto alle sue fonti, però, il libro di Franchini ci mostra anche qualcosa di diverso, e che ha a che fare con l’evoluzione stessa della forma-romanzo in tempi recenti: ci mostra che, oggi, la via più proficua del romanzo italiano (ma non solo) è quella di un recupero, attraverso forme ibride e saggistiche di narrativa, di un autentico discorso sull’uomo e la sua sempre problematica identità; lo ricorda Franchini stesso: «la letteratura di ciò si occupa». Non si tratta certo di un salto indietro; non si tratta di perdere l’autocoscienza acquisita con la (migliore) letteratura postmoderna, piuttosto di metterne in crisi alcuni dogmi. Un buon punto di partenza sarebbe capire una volta per tutte – con l’ultimo Compagnon – che «il fatto che la letteratura parli della letteratura non le impedisce di parlare anche del mondo». O ancor meglio: dell’uomo nel suo rapporto con il mondo. La vera avanguardia è quella che saprà trovare gli strumenti adatti (linguistici, tematici, strutturali) per riproporre quell’interrogazione sull’uomo dalla quale sola dipende la vitalità del romanzo. Ieri come oggi.
[1] Cit. in C.H. Klaus, The Made-Up Self. Impersonation in the Personal Essay, Iowa City, University of Iowa Press, 2010, p.19.
[2] R. La Capria, L’estro quotidiano, Milano, Mondadori, 2005, p.133.
[3] Cfr. Klaus, The Made-Up Self .
[4] Ivi, p.90 e passim.
[5] E. Testa, Eroi e figuranti. Il personaggio nel romanzo, Torino, Einaudi, 2009, p.102.
[6] Cfr. M. Onofri, La ragione in contumacia. La critica militante ai tempi del fondamentalismo, Roma, Donzelli, 2007.
[7] F. La Porta, “Il messaggero”, 15 settembre 2010.

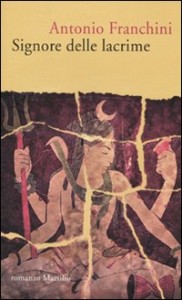
Recent Comments